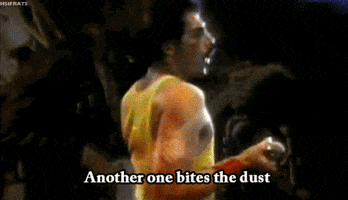Negro, fra i tre, era certamente quello più storicamente attestato, più semanticamente pregnante. Tradizionalmente, identificava una presunta «razza» (la «razza negra», o «i negri», appunto) a cui nei secoli erano state attribuite precise e specifiche caratteristiche, sia fisico-somatiche sia morali (ancora negli anni Cinquanta – anni in cui cominciò a vacillare lo stesso concetto di «razza» – era possibile leggere sullo Zanichelli che «i negri» erano "popoli d'Africa di colore scuro... con cranio stretto e alto, prognatismo... collo grosso, pelle grossolana, statura piuttosto alta, vivaci, facile da imitare...»). Veicolava giudizi di inferiorità. Ed evocava secoli di «razzismo», e di crimini commessi in suo nome. Tuttavia, poteva essere utilizzato – soprattutto, in funzione aggettivale – senza provocare scandalo, o senza essere ritenuto necessariamente offensivo (cfr. F. Faloppa, Parole contro. La rappresentazione del diverso in italiano e nei dialetti, Milano, 2004, pp. 99 sgg.).
Solo all'inizio degli anni Settanta, in seguito alle lotte dei «neri» americani, alcuni traduttori avrebbero cominciato a bandire l'uso di negro in favore di nero, che pareva rendere più fedelmente l'anglo-americano black, assurto a simbolo e parola-chiave dei movimenti per i diritti delle minoranze negli Stati Uniti («Black power», «Black is beautiful»). Cominciò anche a diffondersi l'espressione di colore, calco dall'anglo-americano coloured (che dagli anni Trenta aveva vissuto alterne fortune: cfr. K. Johnson, «The vocabulary of race», in Rappin' and stylin' out. Communication in Urban Black America, a cura di T. Kochman, Chicago, pp. 140 sgg; H. Mencken, The American Language, New York, 1985, p. 381). Ciò non inibì, comunque, la circolazione di negro, che anzi negli anni Ottanta poteva essere usato – con pretesa di neutralità – dai più importanti media nazionali in relazione al fenomeno dell'immigrazione, e alla crescente presenza, in Italia, di immigrati provenienti – in prevalenza – dall'Africa, e quindi «negri» o «neri» per definizione (da un articolo di «Epoca», del 13 dicembre 1987: «... il 24 per cento degli italiani non vorrebbe avere una relazione sentimentale con un negro...»; cfr. Facce da straniero. 30 anni di fotografia e giornalismo sull'immigrazione in Italia, a cura di L. Gariglio, A. Pogliano, R. Zanni, Bruno Mondadori, 2010, in particolare pp. 103 sgg.).
Qualcosa probabilmente cambiò con l'inizio degli anni Novanta, quando importammo il dibattito sul «politicamente corretto» dai paesi anglosassoni (cfr. E. Crisafulli, Igiene verbale. Il politicamente corretto e la libertà linguistica, Roma, 2004; Geoffrey Hughes, Political correctness. A history of Semantics and Culture, London: Wuley-Blackwell, 2010; R. Fresu, Politically correct, in «Enciclopedia dell'Italiano», diretta da R. Simone, Vol. 2, Roma, 2011, pp. 1117-1119). Con degli esiti sia sull'asse paradigmatico – nella scelta, cioè, fra negro, nero, di colore (o afro-americano, che però da noi ha attecchito solo in certi contesti d'uso, e in certi registri) – sia, più in generale, nella percezione del rapporto tra lingua e società, e tra usi linguistici e sensibilità (individuali e collettive). Ricevendo quindi non soltanto indicazioni – secondo alcuni, prescrizioni – lessicali (ad esempio, l'interdizione dei vocaboli anglo-americani negro e nigger, che ha certamente avuto dei riflessi nell'interdizione dell'italiano negro), ma soprattutto spunti di discussione sul valore discriminante di alcune categorie ed etichette verbali all'interno di una società complessa, dove i rapporti di forza e di potere tra la maggioranza e le minoranze passano anche attraverso il linguaggio.